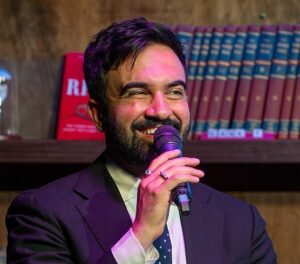”Non si tratta di un’operazione: è una guerra”. Così ufficiali dell’esercito israeliano (Idf) hanno definito i raid partiti nella notte tra giovedì 12 e venerdì 13 verso la Repubblica islamica dell’Iran. L’attacco, denominato “Rising Lion”, aveva l’obiettivo – raggiunto – di eliminare gli alti vertici dell’esercito iraniano e alcuni scienziati del piano nucleare nazionale.
Questo è stato l’inizio del nuovo e violento conflitto che sta illuminando con i razzi una regione, il Medio Oriente, già martoriata dai conflitti, alcuni dei quali ancora in corso, come quello a Gaza. Questa guerra fa sorgere tanti “perché?”: perché Israele ha aperto un nuovo fronte? Perché contro l’Iran? Perché adesso? E tanti altri. Per rispondere a queste domande bisogna partire osservando da vicino gli attori e i loro interessi in nuovo scacchiere bellico.
Casus belli: il piano nucleare iraniano
Israele ha giustificato la sua azione bellica come una “guerra preventiva” contro l’Iran, accusandolo di star progettando la costruzione della bomba atomica. L’accusa parte dal fatto che la Repubblica islamica, pur disponendo ufficialmente di un programma nucleare civile, ha portato il livello di arricchimento dell’uranio ben oltre i limiti compatibili a questo tipo di utilizzo. Nello specifico, mentre l’arricchimento massimo considerato accettabile per scopi civili si aggira intorno al 20%, l’Iran ha raggiunto il 60%, una soglia pericolosamente vicina al livello richiesto per la costruzione dell’ordigno nucleare: il 90%. Intraprendendo questo processo di arricchimento, Teheran è venuto meno a quanto stabilito dall’“Accordo sul nucleare iraniano” (JCPoA), un trattato internazionale cruciale in questa storia.
L’Accordo, stipulato nel 2015, consentiva all’Iran di mantenere il proprio programma nucleare, ma solo a certe condizioni e per fini esclusivamente civili, così in cambio si sarebbero sospese molte sanzioni economiche. I paesi firmatari, oltre all’Iran, erano Unione Europea, Francia, Regno Unito, Germania, Cina, Russia e, in ultimo, Stati Uniti. Dopo i primi anni di relativo successo, però, l’arrivo della prima presidenza Trump stravolge tutto. Nel 2018 Trump rescinde unilateralmente l’accordo e reintroduce le sanzioni, spingendo l’Iran a riprendere l’arricchimento oltre i limiti stabiliti. Da allora, nonostante anche alcuni tenui tentativi della presidenza Biden, i negoziati per rilanciare l’intesa si sono arenati tra tensioni politiche e scarsa fiducia reciproca.
Negli ultimi mesi era ripreso, seppur timidamente, il dialogo tra Stati Uniti e Iran sulla questione nucleare, senza però produrre risultati concreti. Circa due mesi fa, i colloqui si erano conclusi con un nulla di fatto, ma con l’intenzione di aggiornarsi a un nuovo incontro, previsto per la scorsa domenica in Oman. Tuttavia, il raid israeliano ha spinto Teheran ad accusare Washington di complicità con Israele, decidendo di conseguenza di disertare il vertice. Nel frattempo, pochi giorni fa, l’Aiea (Agenzia internazionale per l’energia atomica), l’organo dell’Onu che supervisiona l’utilizzo dell’energia nucleare ha emesso una risoluzione storica, dichiarando per la prima volta in vent’anni che l’Iran non sta rispettando i suoi obblighi sulla non proliferazione nucleare.
La preoccupazione per l’arricchimento dell’uranio spiega perché tra le persone uccise da Israele nel primo raid compaiono nove tra scienziati e tecnici di alto profilo, definiti dall’Idf come “fattori chiave nello sviluppo delle armi nucleari”. Si tratta quindi di un duro colpo per il piano nucleare iraniano, o, almeno, per quanto riguarda il capitale umano. Infatti, i raid israeliani, pur avendo colpito con successo alcuni siti nucleari, non sono riusciti – né possono riuscirci ora – a colpire duramente i principali centri della ricerca nucleare iraniana, come quelli di Fordow e Isfahan. Questo perché tali centri sono situati sottoterra, dentro le montagne, e protetti anche da qualche metro di cemento armato. C’è solo uno stato che possiede la tecnologia per penetrare questi “bunker”: gli Stati Uniti.
Ad ogni modo, l’operazione israeliana ha inferto un duro colpo all’Iran, che in una notte si è visto decapitare l’apparato militare e quello del progetto nucleare. Israele definisce da anni Teheran come il proprio nemico esistenziale, ma non si era mai spinto a un attacco così diretto e così su larga scala. E un motivo in particolare c’è: la Repubblica islamica non è mai stata così debole.
Iran, un gigante dai piedi di argilla?
La Repubblica islamica ha un’ambizione: diventare la potenza egemone del Golfo persico. Contestualmente, ha cercato anche di porsi come guida ideologica, propagandando una ferma convinzione di eliminare l’“entità sionista”, ossia Israele. Questo sogno di grandezza, però, si scontra con la presenza di altre grandi potenze della regione, in primis l’Arabia Saudita, e più recentemente da una progressiva perdita di influenza, determinata sia da un’economia interna in difficoltà sia dalla situazione di difficoltà dei suoi principali alleati dell’“Asse della resistenza”.
Elemento cruciale della politica estera dell’Iran è questa Asse della resistenza, una coalizione costituita per garantirsi il suo ruolo egemonico nella regione contro l’influenza degli Stati Uniti. Questa alleanza terroristica era composta originariamente dal regime di Assad in Siria e da milizie militari sparse in tutto il Medio Oriente, in particolare gli Houthi in Yemen, Hezbollah in Libano e Hamas in Palestina. Questi attori, però, sono essenzialmente dei proxy, cioè organizzazioni sostenute, economicamente e militarmente, da Teheran per i suoi scopi. Architetto di questa struttura reticolare ben organizzata fu il generale Soleimani, ucciso da un raid statunitense nel 2020. La sua morte, in un certo senso, è stata la prima crepa dello sgretolarsi dell’Asse della resistenza: uno dopo l’altro, i principali alleati dell’Iran sono caduti o hanno ridimensionato enormemente le loro capacità strategiche. In breve tempo, Teheran si è ritrovata senza forti alleati nella regione: a settembre 2024 un attacco su larga scala di Israele ha eliminato i vertici e la forza militare di Hezbollah, a dicembre il regime di Assad è stato deposto dalla coalizione dei ribelli, gli Houthi, sebbene siano ancora una minaccia per il commercio marittimo del Mar Rosso, devono fronteggiare i bombardamenti statunitensi e, infine, i miliziani di Hamas sono assediati a Gaza.
Anche sul fronte interno l’Iran ha le sue fragilità: l’economia arranca e la popolazione sopporta sempre meno il regime degli ayatollah. È in questa direzione che si potrebbero leggere l’elezione nel 2024 del presidente riformista Pezeshkian e, ancora più evidentemente, le proteste del movimento “Donna, Vita, Libertà”.
Israele ha così scelto di attaccare la sua nemesi in questo momento di debolezza e, soprattutto, prima che possa acquisire la bomba atomica. Il premier israeliano, Netanyahu, ha affermato che uno degli obiettivi di questa guerra è il regime change, cioè rovesciare il regime politico attuale in Iran. Il primo ministro non ha specificato esattamente quale nuovo regime dovrebbe instaurarsi (né tanto meno quanto questo obiettivo sia realmente realizzabile), ma è facile ipotizzare che sia un tradizionale “esportare la democrazia” statunitense, un’azione che, laddove attuata, ha generato instabilità politica, povertà e conflitti. D’altro canto, per il premier Netanyahu l’apertura di questo nuovo fronte potrebbe portare benefici.
Le tensioni interne a Israele e il futuro del governo di Netanyahu
Da un punto di vista politico, la carriera di Netanyahu sembra finita: il fallimento nel prevenire la strage del 7 ottobre, il massacro a Gaza e gli ostaggi (o almeno i loro corpi) ancora in mano ad Hamas sono le accuse che una crescente parte della popolazione israeliana muove contro di lui. E questo malumore è registrato dai sondaggi israeliani, secondo cui la sua coalizione registra un livello basso di consenso e l’opposizione, se si votasse oggi, potrebbe ottenere la maggioranza nella Knesset, il parlamento israeliano. In questo contesto, una guerra contro un nemico esterno percepito – e soprattutto propagandato – come una minaccia esistenziale, cioè in grado di annientare il proprio stato, può contribuire a ridurre l’attenzione mediatica su altre questioni politicamente sensibili e le divisioni interne a una società profondamente polarizzata come quella israeliana, rafforzando il sostegno al governo durante questo periodo di crisi. È il fenomeno noto, nelle relazioni internazionali, come rally ’round the flag. Dunque, mantenere uno stato di guerra risulta per Netanyahu e il suo governo la chiave per restare al potere. Infatti, l’Idf non ha dubbi: quello iraniano è il “fronte di guerra primario”, mentre Gaza viene relegata così a un fronte secondario. Inoltre, poter vantare una vittoria sull’Iran (anche se sarebbe da capire cosa intendere come vittoria) potrebbe essere per Netanyahu un’importante carta da giocare per restare ancora nel gioco della politica israeliana.
D’altro canto, la coalizione di Netanyahu sembra scricchiolare. Mercoledì 11 il governo è sopravvissuto a un voto di sfiducia per un pugno di voti. La votazione era stata richiesta dall’opposizione dopo giorni di tensione interne alla maggioranza sulla questione dell’esenzione alla leva per gli ultraortodossi. A riguardo, due partiti religiosi avevano togliere il loro appoggio e votare quindi la sfiducia se non si fosse trovato un accordo per garantire tale esenzione.
Gli “altri” di questa guerra
Sul campo di battaglia per ora ci sono solo Israele e Iran, ma altri Stati potrebbero entrare in gioco, anche non militarmente.
L’elefante nella stanza sono ovviamente gli Stati Uniti di Trump. Poco dopo l’attacco, il presidente aveva dichiarato che quello era per l’Iran la conseguenza di non aver stipulato l’accordo con lui e che i danni potrebbero essere peggiori. Washington era certamente al corrente dell’imminente attacco, ma ciò che non è chiaro è se fosse completamente d’accordo o meno. Sebbene sui social abbia accolto con favore l’attacco e non abbia escluso un intervento diretto degli USA, Trump ha incentrato la sua politica estera sul disimpegno dai conflitti esteri, quindi potrebbe in realtà cercare un accordo e arrivare a una de-escalation. Anche se non sarebbe così strano che cambiasse idea…
Ci sono poi le monarchie del Golfo persico, in particolare Arabia saudita ed Emirati arabi uniti. I due Stati hanno rapporti cooperativi con Israele, mentre sono avversari strategici dell’Iran, sebbene negli ultimi due-tre anni abbiano avviato un canale di comunicazione attivo, anche dopo i fatti del 7 ottobre. Le due monarchie hanno condannato l’attacco israeliano e auspicato una veloce de-escalation per ricostruire una certa stabilità nella regione. Una condizione che, oltre a essere ottimale per la tutela delle vite dei civili, garantisce loro la stabilità dei loro commerci. Potrebbero per questo agire come mediatori tra le due parti.
Chi invece si è già proposto come mediatore è Vladimir Putin, sicché la Russia è uno dei grandi alleati dell’Iran. Mosca ha poi un interesse strategico in particolare per concludere questo conflitto per una questione ben precisa: i droni. La Repubblica islamica è infatti il principale fornitore dei droni utilizzati dall’esercito russo nella guerra contro l’Ucraina. Perciò per Putin è cruciale che questo nuovo conflitto si concluda.
Anche un altro grande alleato iraniano è interessato a concludere presto il conflitto: la Cina. Al momento Pechino sta in una posizione più defilata, probabilmente per non entrare in scontro con gli USA, ma certamente auspica a una fine breve del conflitto in quanto dall’Iran importa grandi quantità di petrolio a basso prezzo. Se l’import del petrolio iraniano dovesse calare significativamente, per le aziende cinesi questo si tradurrebbe in costi dell’energia più elevati e, quindi, beni più costosi per gli acquirenti (ossia, anche noi europei).
Infine, ci sono Unione Europea e Stati membri. Al momento non sembrano esserci significative proposte dal Vecchio Continente, se non qualche dichiarazione o promessa di supporto a Israele contro l’Iran da parte del presidente francese Macron e dalla presidente della Commissione europea von der Leyen. Tuttavia, potrebbe emergere qualcosa di interessante dal tavolo del G7 in Canada.
Quindi, cosa aspettarsi?
La situazione è complessa e i prossimi scenari possibili di questo conflitto sono diversi, ma c’è una cosa che è certa: aumenteranno i morti. Secondo fonti ufficiali, al 16 giugno, quindi dopo “solo” quattro giorni di conflitto, il bilancio è in Israele di 24 vittime e circa 600 feriti e in Iran di 224 vittime e oltre 1200 feriti. La quasi totalità dei morti e dei feriti erano civili e tra loro anche bambini. La loro colpa? Essere nel posto sbagliato al momento sbagliato. O meglio, essere nello stato sbagliato al tempo di governi sbagliati. Infatti, se c’è una cosa che tutte le guerre passate dimostrano è che la conta dei morti e dei feriti cresce ogni giorno di più, indipendentemente dai moventi del conflitto e da chi ne esce vincitore.
Rimane così sospesa un’ultima domanda, certamente antica ma forse ancora senza una vera risposta: perché la guerra?
A cura di
Niccolò Bonato